Note e appunti sul concetto di cultura cinematografica a Gorizia Parte II: lo stato dell’arte contemporaneo
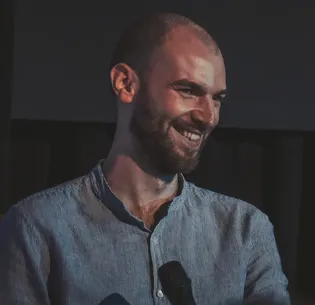
Guardando agli ultimi quarant’anni di storia dei rapporti tra il cinema e Gorizia, e osservando nello specifico le principali istanze di riferimento responsabili tanto della sopravvivenza di questi rapporti, quanto dell’evoluzioni di questa stessa rinnovata cultura, non si può oggi fare a meno di notare un’evidente distinzione da dover sottoporre all’attenzione di chi legge. La cultura cinematografica del passato, benintesa nelle attività, nelle iniziative e nelle persone che l’hanno resa tale, come visto nel precedente intervento, non esiste più. Al suo posto, si è fatta progressivamente spazio una nuova cultura cinematografica, alimentata da nuove attività, nuove iniziative e nuove persone ben consapevoli del decentramento del medium nei discorsi mediali del tardo Novecento e di questo millennio. Il cinema, infatti, non è più al centro del dibattito culturale. I cosiddetti “nuovi media” o, per meglio dire, “media audiovisivi alternativi”, ne hanno spodestato definitivamente il suo statuto principe, incentivando di riflesso gli studi e le attenzioni sul medium a trovare nuovi spazi e nuove formule in linea con i tempi. Questo fenomeno, tanto culturale quanto industriale, è stato anzitempo annunciato dalle lungimiranti considerazioni di teorici del cinema quali, su tutti, Francesco Casetti, che parlando di “rilocazione” del cinema ha intravisto nei numerosi media audiovisivi le nuove vie di fuga dell’immagine in movimento. Essendo quindi il cinema ovunque, urge ripensare formule, spazi, discorsi. Procediamo però con ordine riprendendo il filo del discorso dai nostri due protagonisti, Darko Bratina e Sandro Scandolara.
La prima retrospettiva sul cinema sloveno, e gli approfondimenti televisivi a questo dedicati, assumono per i popoli cittadini della Gorizia di quel tempo un impareggiabile valore socioculturale. Il cinema, nelle sue proprietà linguistiche, acquista infatti in quelle occasioni un indubbio valore identitario non solo per il popolo sloveno, che grazie al medium può riscoprire, come ricordato da Bratina, segmenti delle proprie radici storiche, bensì per la cittadinanza goriziana in sé, figlia di una commistione interculturale e transfrontaliera per sua stessa cultura storico-geografica. A questi appuntamenti se ne aggiungono presto di ulteriori, nati e coltivati proprio in quegli stessi anni. In modo particolare, è una novità proposta alle soglie degli anni Ottanta ad attirare su di sé, ancora oggi, i riflettori cinematografici della città. Il 1° agosto 1981, nella splendida cornice del castello di Gorizia, si tiene una manifestazione commemorativa alla persona e all’opera dello sceneggiatore Sergio Amidei, soli pochi mesi prima scomparso all’età di 76 anni. A pensarla a monte, facendosene da subito carico, è lo stesso Darko Bratina, affascinato dalla figura di Amidei e dal colloquio avuto con lui a Belgrado nel 1977. È proprio in quell’occasione, dialogando sulle origini della madre dello sceneggiatore, cresciuta a Salcano, che Bratina propone di dedicargli un grande omaggio nella città goriziana, predisponendo un accurato programma composto da 22 titoli da questo sceneggiati e che sarà quindi alla base, in quel lontano agosto del 1981, della manifestazione dal titolo “La figura e l’opera di Sergio Amidei nel cinema italiano”. L’allora sindaco di Gorizia, Antonio Scarano, vedrà nell’evento il potenziale per una seconda e per ulteriori edizioni in divenire, sebbene si parlerà di vero e proprio “Premio alla Miglior Sceneggiatura Internazionale Sergio Amidei”, denominazione corrente, soltanto anni più tardi, grazie anche all’intuizioni di costituire nel 1992 un’associazione culturale dedicata allo sceneggiatore. Padre di questa intuizione è soprattutto Giuseppe Longo, attuale direttore artistico del Premio che, accanto ad amici e amiche dell’epoca quali Nereo Battello, Dorella Cantarut, Gabriella Gabrielli, Ivo Mauri, Rodolfo Ziberna e molti altri, raccoglie l’idea originale di Bratina, anch’egli tra i nomi firmatari dell’associazione, dando così alla manifestazione nuovo slancio e nuova linfa. Eppure, nonostante il successo e l’eco ottenuto da eventi come questi, Gorizia non può ancora di certo definirsi “una città del cinema”. A precisarlo sono più volte gli stessi Bratina e Scandolara, come testimoniato dai loro scritti, desiderosi di fare di questo luogo un punto di riferimento per la cultura cinematografica. Gli elementi che forse più di altri hanno contribuito, e contribuiscono tuttora a dare seguito e speranza a questo desiderio, sono gli sforzi manifesti attorno alla filiera produttiva tout court. Alle precedenti occasioni di dibattito nei cineforum e nei circoli cittadini e, segnatamente, alle neonate e ancora oggi presenti manifestazioni culturali come il “Premio Amidei”, “Omaggio a una visione” e convegni come questi, si sono via via affacciate in città e, più in generale, nel territorio goriziano, una serie di realtà produttive che hanno dato i natali a diverse figure autoriali e a maestranze oggi attive a livello locale, nazionale e internazionale. La presenza nel territorio di soggetti ed enti specializzati nella produzione di testi audiovisivi non è però cosa nuova e attribuibile solo agli ultimi quarant’anni di storia goriziana. Si è infatti già accennato nell’intervento precedente alle prime esperienze produttive e amatoriali incentivate, a Gorizia così come in gran parte del territorio italiano dell’epoca, dalle organizzazioni aderenti soprattutto al Partito Nazionale Fascista. Non diversamente, si è poi fatto inoltre cenno alle gloriose, seppure fugaci e temporanee avventure dei cineamatori goriziani che per primi, a partire dal secondo dopoguerra, hanno animato un vero e concreto dibattito sulla produzione cinematografica nel territorio. Fautori e intrepidi promotori di questo movimento sono, in particolare, i giornalisti Ugo Pilato e Quarto Cossi, ambedue con precedenti esperienze produttive proprio nei contesti della già citata Opera Nazionale Dopolavoro e dei festival del Littorio tanto voluti da Mussolini e dal regime. Le loro vicende, alle radici di una florida attività cineamatoriale che coinvolse, ugualmente, numerosi altri cittadini goriziani e che produsse un cospicuo numero di film a formato ridotto tra il 1953 e il 1966, è stata a mio dire perfettamente raccontata da Martina Pizzamiglio, la quale ha saputo dare voce e risalto a una ricca microstoria altrimenti destinata a scomparire alla stregua di molte altre. Nonostante gli esiti produttivi di quell’esperienza condivisa, i discorsi sulla produzione cinematografica e audiovisiva tornano in auge a Gorizia soltanto a partire dagli anni Ottanta. Tra le prime micce che hanno reso possibile il ritorno in città di simili progetti, vi è senza ombra di dubbio l’inaugurazione, nel 1977, del circolo cinematografico Kinoatelje. L’ente, fondato come già in precedenza ricordato da Bratina, si impegna sin da subito nel promuovere il sapere e la cultura cinematografica slovena organizzando numerose iniziative, celebre ad esempio quella del “Film Video Monitor”, e ponendosi quindi alla testa di progetti audiovisivi oggi rimasti nella memoria e negli archivi del territorio. Tra i molti, ricordiamo anzitutto in questa sede i lavori di alcuni registi come Andrej Mlakar, Danijel Jarc e Boris Palčič, tra i primi a fare del Kinoatelje un vero e proprio soggetto produttivo. Mlakar, in particolare, ne firma il primo progetto da questi realizzato in collaborazione con l’emittente slovena RTV Ljubljana, Zamejci, del 1989, film nel quale sono raccontate le abitudini, le tradizioni e i riti delle comunità slovene di Gorizia, Trieste e delle Valli del Natisone e che si avvalse del contributo, in sceneggiatura, dello stesso Darko Bratina. Le ritualità canoniche goriziane sono protagoniste anche del film La fiera delle identità, diretto da Jarc nel 1992 e realizzato sempre in collaborazione con l’emittente slovena. Il racconto filmico si articola nelle tradizionali giornate celebrative della fiera di S. Andrea, mostrandone dapprima i principali risvolti e punti di incontro, sino a offrire poi non scontate occasioni di riflessione sul tema del confine, dell’identità, sul senso di appartenenza e sui terribili conflitti che hanno interessato, e che all’epoca interessano ancora, parte del territorio. Anni più tardi sono invece le registe Anja Medved e Nadja Velušček, e i colleghi Dorino Minigutti e Alvaro Petricig a firmare la maggior parte delle opere prodotte in casa Kinoatelje. Medved e Velušček esordiscono, infatti, nel 1999, dirigendo a quattro mani il film Non volavano uccelli, documentario sulle memorie dei giorni di guerra vissuti dai novantenni del territorio, all’epoca bambini inermi, e sulle lore percezioni delle conseguenze del conflitto realizzato alla luce di accurate ricerche condotte a partire da informazioni emerse da interviste, periodici, pubblicazioni varie e diari privati. Assieme, la coppia dirige in seguito altri progetti, sempre prodotti dall’ente, come Il mio confine (2002), La città sul prato (2004), Il tempo del fiume (2010), Le memorie degli incendi (2017), sino quindi a fondare la casa di produzione Kinokašča e continuare così a lavorare nel settore. In anni ancora più recenti, sono altri registi come Leo Černic, Jan Mozetič, Jan Devetak e, non da ultimo, Giulio De Paolis ad alimentare in via ulteriore con le rispettive opere tanto la storia produttiva del Kinoatelje, quanto il paesaggio produttivo contemporaneo del territorio.
Il conformarsi negli anni di questo stesso paesaggio non può però essere merito soltanto delle molte iniziative e dei progetti promossi dall’ente e dai soggetti sino a qui menzionati. Al contrario, sono in molti altri ad arricchirne il valore produttivo. Matteo Oleotto, per forza di cose, è oggi probabilmente il regista di riferimento del settore audiovisivo goriziano. Il suo expertise, alla base ormai di numerosi progetti di rilevanza nazionale, è di fatto il frutto di quello stesso humus culturale di cui si costituisce la Gorizia produttiva degli anni Novanta e dei primi anni Duemila, e che nel caso di Oleotto ha origini tanto nell’esperienza con il Kinoatelje, quanto nel precedente progetto con il collettivo Kairos. Inaugurato nel 1996, per iniziativa di un gruppo di appassionati cinefili e cinefile, tra cui Giuliana Bellini, Sabrina Del Neris, Emilio Quinzi, Noemi Lakovic e Oleotto medesimo, Kairos nasce da una collaborazione stretta con il Dipartimento di Salute Mentale dell’ex O.P.P. di Gorizia con l’intento di realizzare attività, iniziative culturali e cortometraggi al fianco del personale e degli utenti dell’istituto. Ed è proprio in questo contesto che Oleotto realizza il suo primo cortometraggio, La luna ci guarda (2001), ispirato dall’annuncio di un concorso sulle fiabe pubblicato dalla stampa locale. Contestualmente, nascono a Gorizia altri progetti come il sovversivo “6x60”, format coordinato da Gianandrea Sasso e organizzato, tra il 2007 e il 2010, dall’associazione Makingo presieduta da Francesco Berni. L’iniziativa, che in quegli anni coinvolge volti e nomi oggi più o meno noti nel territorio, ha il suo quartier generale negli spazi di Palazzo del Cinema e invitava i partecipanti a realizzare entro le sessanta ore stabilite, dei cortometraggi dalla durata massima di sei minuti che tenessero conto di prompt e limiti stabiliti a monte dagli organizzatori. Una particolarità, questa del format, che si rivela essere parte del suo stesso successo sin dalla prima acclamata edizione e che oggi, ad associazione sciolta, continua a proseguire altrove per mano di un gruppo di cinefili ugualmente appassionati. Più strutturate sono invece le esperienze odierne delle società di produzione Staragara IT, coordinata da Miha Černec e David Cej e fautrice, negli ultimi anni, di numerosi progetti in collaborazione tra Slovenia e Italia; della Tesla Production, fondata nel 2017 dall’intuito della produttrice Chiara Toffolo e del regista Cristian Natoli; e di Galaxia, diretta da Antonella Perrucci e ormai celebre agenzia di casting con a curriculum importanti progetti parimenti in qualità di casa di produzione.
Insomma, un parterre di soggetti, di eventi e progetti che fanno di Gorizia, e del suo territorio, un paesaggio socioculturale e uno scenario produttivo dove l’industria ha saputo negli ultimi anni evolversi a seconda delle esigenze del medium, rincorrendo prima e raggiungendo poi ambizioni ed esiti condivisi, per concretizzare – sebbene forse ancora in parte – quello stesso sogno di due pionieri della cultura cinematografica goriziana a cui ancora oggi guardiamo con affetto, stima ed entusiasmo. Una lezione, la loro, che sa dunque e saprà sempre ispirare i sognatori e le sognatrici dell’oggi e del domani.
Autore: Steven Stergar
Annunci/
Cinema a Udine
07. 01. 2025Per parlare del cineclubismo udinese bisogna partire da Guido Galanti, che nel 1930 fondò il Cine Club Udine – il terzo, in ordine temporale, in tutt’Italia. Accanto a lui bisogna menzionare almeno Renato Spinotti (zio di Dante Spinotti). Il Cine Club produce in 16mm nel 1934 il mediometraggio Giornate di sole, una commedia diretta e interpretata da Galanti e fotografata da Spinotti (con un cartello iniziale con l’angelo del colle di Udine disegnato a mano e la scritta “La Galanti Film presenta”). Autore: Giorgio Placereani
Trieste, ovvero il mondo in una città
07. 01. 2025Oggi proverò a sintetizzare il percorso della cultura cinematografica a Trieste. Parlerò di fatti abbastanza noti, come lo sguardo benevolo degli scrittori e intellettuali triestini verso il cinema, o del ruolo di ponte della città tra il cinema occidentale e orientale. Ma vorrei mettere anche in evidenza un fattore finora più trascurato, ovvero la presenza femminile negli anni nella cultura cinematografica triestina. Autore: Paolo Lughi
Note e appunti sul concetto di cultura cinematografica a Gorizia Parte I: origini e tappe di una fortuna critica
07. 01. 2025Il cinematografo dà per la prima volta spettacolo di sé a Gorizia nel tardo pomeriggio dell’8 dicembre 1897, due anni dopo le prime proiezioni pubbliche parigine dei fratelli Lumière, nella corte interna dell’allora hotel Centrale, affacciato sull’attuale Corso Verdi. L’arrivo del medium è solo l’ultima novità tra gli elementi di ammodernamento che la città mitteleuropea registra in quel momento storico. Autore: Steven Stergar

